


IL PERSONAGGIO
a cura di Anna Osellame
Quando mi è stata proposta l’idea
di questa tesi ho incontrato molte difficoltà, tanto da aver pensato
più volte di lasciare questo progetto, ma più cercavo e
più chiedevo alla gente comune più mi innamoravo della figura
di Alberto Ancilotto.
L’aneddoto che vi sto per raccontare vi dimostra quanto fosse affascinante
e quanto mi abbia affascinato. Un giorno ero seduta ad aspettare mio fratello
che faceva una visita e stavo correggendo un pezzo della mia tesi, si
è avvicinato un signore incuriosito dai miei fogli, quando gli
ho spiegato che si trattava del conte Alberto Ancilotto sono rimasta sorpresa
nello scoprire che non solo conosceva il conte, ma conosceva anche i suoi
documentari. Di tutta risposta il signore mi ha detto: sarò anca
portier, ma del conte no me desmentego.
Più o meno la stessa opinione è emersa tutte le volte che
ho intervistato qualcuno, un personaggio stimato per la sua generosità
e ricordato con grande affetto.
Il conte carlo Alberto Ancilotto nacque il 20 dicembre del 1902 in Borgo
Cavour a Treviso, ma fu conosciuto sempre con il solo nome di Alberto.
Terzo di tre figli maschi appare in una foto dei primi del novecento in
abiti da bambina, forte era il desiderio della madre di avere una figlia
femmina.
Alberto iniziò gli studi classici presso il ginnasio di Treviso,
ma lo scoppio della prima Guerra Mondiale lo costrinse ad abbandonare
la scuola che non finì mai.
Alberto fu un giovane dinamico, pieno di interesse e passioni, si dedicò
per un periodo al canottaggio partecipando a numerose gare in zona.
Fin da giovane fu un amante della caccia e di cani da caccia, un interesse
comunque in voga tra i nobili dell’epoca. La passione più
importante della sua giovinezza furono comunque le automobili a cui dedicò
buona parte del suo tempo libero e delle sue energie. Nel 1924 vinse la
prima edizione della gara Vittorio Veneto – Cansiglio e fu soprannominato
in quell’occasione “asso del volante”.
Nel 1931 Alberto sposò Maria Teresa Catemario di Quadri e con lei
si trasferisce nella villa di Crocetta del Montello per seguire appunto
le sorti della filanda. Qui poteva disporre di un grande parco, ed Alberto
fece costruire subito un pollaio per le galline e un recinto per i cani
da caccia (passione che non abbandonò mai): non sarà che
l’inizio di un grande amore per gli animali.
Dal loro matrimonio nacquero il conte Enrico Agostino e conte Carlo Eugenio
Riccardo Maria, conosciuto come Carletto, venuto a mancare qualche anno
fa.
Attorno al 35 scoprendo il piacere della fotografia Alberto adibì
il terzo piano della villa a camera oscura per lo sviluppo delle foto,
oltre alle foto di famiglia, impresse il ciclo della vita dei i bachi
da seta e le varie fasi della filatura dei bozzoli.
Dopo una notevole esperienza in campo fotografico Alberto Ancilotto si
avvicinò al documentarismo, raggiungendo il primo successo nel
1939, con un documentario su un caso di estrofia totale della vescica
urinaria in un giovane di 22 anni, un filmato che fu giudicato di grande
sapienza tecnica, per il modo in cui era riuscito a documentare le fasi
di una difficile operazione chirurgica.
Girò in quegli anni all’interno della filanda il documentario
Industria meravigliosa che racconta le fasi di lavorazione della seta.
La famiglia Ancilotto a Cortina d’Ampezzo possedeva una casa, dove
Alberto si recava spesso e volentieri nei mesi invernali con i figli e
la moglie. Nel 1941 girò un importante documentario, I campionati
mondiali durante i mondiali di sci svoltisi a Cortina, questo lavoro è
diventato di importanza storica per la città di Cortina d’Ampezzo
e per la storia dei mondiali di sci (anche se non fu riconosciuta come
gara mondiale).
Sempre nel campo dello sci girò un cortometraggio con Leo Gasperl,
allenatore della nazionale di sci, che insegna a sciare e un corto
I legni sulla neve con Eugenio Monti e Zeno Colò giovanissimi.
Tra il 46 e il 50 Alberto collaborò con il famoso fotografo di
treviso Bepi Fini e assieme girarono un documentario su Antonio
Canova, giudicato di ottima qualità per l’attenzione
con cui le sculture furono riprese, e girarono due documentari su Palladio
oggi conservati presso l’Istituto Luce.
Ma il colpo di fulmine avvenne dopo la seconda guerra mondiale, quando
il figlio maggiore, Enrico si iscrive all’università e sostiene
l’esame di entomologia: è l’inizio di un grande amore
per gli animali minori. Abbandona la maggior parte dei suoi contatti con
la nobiltà trevigiana e passa le sue giornate e le sue nottate
filmando i cicli biologici di cavallette, libellule, ragni, mosche e quant’altro.
E inizia una raccolta di esemplari di farfalle del Montello, donata al
prof. Zangheri.
Il 1951 segnerà un anno di svolta nel lavoro di documentarista
di Alberto. Alla Mostra del cinema di Venezia nella sezione speciale documentari
presenterà L’Epeire fasciata, il racconto
della vita di un ragno dei nostri giardini. Nonostante il piccolo errore
(epeira e non epeire è il termine corretto) il successo fu strepitoso.
Il documentario fu giudicato un autentico capolavoro del documentarismo
nazionale, un capolavoro di tecnica e didattica, con grande cura del contrasto
fra il bianco e il nero ricevette la nomination all’Oscar
nella sezione documentari corti e il titolo fu tradotto negli Usa in The
garden spider (Epeira Diadema).
Nel 1952 girò tre documentari con la compagnia di marionette
i Piccoli di Podrecca, uno dei quali vinse il primo premio come
miglior film per ragazzi alla mostra di venezia, forse non un premio prestigioso,
ma Alberto dimostrava capacità, creatività e intelligenza
nell’aver documentato l’operato di un personaggio e delle
sue marionette che ancor oggi è conservato dal teatro stabile di
Udine.
Sempre nel 1952 alla mostra del cinema di Venezia, ma nella sezione documentari
presentò un documentario dal titolo Mantide religiosa
che vinse il secondo premio, in sala c’era un giovane studente romano
di medicina che rimase incantato e che divenne il suo miglior collaboratore
ed è il qui presente Fernando Armati.
Assieme girano una serie entomologica tra il 1950 e il 1960: Gli
insetti, Il pantano, I coleotteri, I ditteri, I lepidotteri, Gli optodotteri.
E tantissimi altri documentari: La metamorfosi dei lepidotteri,
Le piante vivono, I sauri, Gli Anfibi, I camaleonti, Fisiologia dei vegetali,
L’isola del vetro, Le isole della laguna, dodici puntate per la
rai Conoscere la natura e alcune puntate per la BBC. Tutti i
documentari sono prodotti dalla Montello film di proprietà di Alberto
Ancilotto. I luoghi deputati alle riprese sono le zone intorno a Crocetta
del Montello, il giardino della villa, il Cansilgio, il Piave e soprattutto
il Montello.
Oltre a Fernando Alberto si affidò ad una troupe costituita da
persone a lui molto vicine e care, primo fra tutti il giardiniere della
villa, Paolin Binotto che si occupava di ricostruire
gli ambienti adatti per gli insetti. Giulio Vianello
detto Ciccio ciclista e violoncellista amico di Alberto che si occupava
delle parti meccaniche. Carletto Walter Zanoni, amico
d’infanzia, il cui compito era legato all’elettronica. A queste
persone se ne sggiungevano altre a seconda delle necessità: per
le consulenze scientifiche il prof Milo Burlini, il prof. Sergio Zangheri
e il prof. Sandro Ruffo, il montaggio era affidato a Pino Giomini, le
musiche a Giuliano Pomeranz, a Franco Mannino, al maestro Nascimbene e
tantissimi altri personaggi importanti.
Il parco della villa di Crocetta del Montello divenne presto la casa per
moltissimi animali di ogni specie: delle scimmie, degli orsi, una volpe,
scoiattoli, il leopardo Giacomi che molti di voi ricorderanno di cui Alberto
e il personale della villa si occupavano con grande amore.
La villa era diventata un vero laboratorio
scientifico, per animali provenienti da climi tropicali e desertici che
richiedevano cure particolari. Alberto creò degli ambienti con
umidità e temperatura controllati, con lampade sterilizzate per
evitare il diffondersi di muffe e parassiti per tali creature (le iguane
per esempio, i camaleonti). Inoltre trasformò una vecchia incubatrice,
per le uova dei polli, in un gigantesco terrario climatizzato dove faceva
nascere le cavallette per nutrire gli ospiti carnivori.
Il 1957 segna un’altra svolta nella vita di Alberto Ancilotto. Il
due giugno di quell’anno in un incidente automobilistico perse la
vita la moglie Maria Teresa.
In quello stesso anno dopo anni di riprese e di studi portò a termine
il suo unico lungometraggio 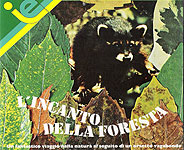 L’incanto
della foresta che ebbe un successo internazionale tanto
da essere distribuito in lingua spagnola, inglese, tedesca e svedese.
L’incanto
della foresta che ebbe un successo internazionale tanto
da essere distribuito in lingua spagnola, inglese, tedesca e svedese.
E’ il lavoro più importante di Alberto perché riassume
tutti i doc fino a questo momento girati.
L’incanto della foresta è la storia di un
orsetto vagabondo che lascia la mamma e i fratellini per scoprire il segreto
che gli permetterà di diventare un orso grande e coraggioso.
La voce narrante è di Stefano Sibaldi che con calzante ironia parla
a Pikisò e allo spettatore.
Il Quartetto Cetra, famoso negli anni cinquanta per le musiche per il
cinema e anche per alcuni caroselli, ci presenta Pikisò con una
canzone, che sarà il leitmotiv di tutto il film.
Pikisò approfittando di un momento in cui mamma e fratelli fanno
il bagno nel Piave scappa via verso la foresta, alla ricerca del gufo
sapiente, il quale conosce il segreto per far diventare d’un colpo
grandi i piccini. Pikisò capita in un circo dove i ragni trapezisti
e i ragni acrobati compiono grandi evoluzioni. Pare che il segreto per
diventare grandi sia comunque annusare i papaveri e attraverso mille avventure
e incontri Pikisò cercherà un campo di papaveri. Dopo una
dormita tra il canneto Pikisò assiste ad una serie di stupende
metamorfosi, anche la voce fuori campo rispetta il silenzio. la libellula
ripresa da varie angolazioni (le riprese sono state fatte in laboratorio)
compie la trasformazione, la cavalletta fa la muta, il bruco che deve
andare a passeggio cambia abito (la camera lo segue con un primo piano).
Ma sono le farfalle a stupire di più, come può essere che
da certi brutti bruchi escano tante belle farfalle? la telecamera coglie
la metamorfosi di una farfalla passo dopo passo, emozionando Pikisò,
ma soprattutto lo spettatore.
Ancora, la telecamera riprende il lavoro delle formiche per farlo fu costruito
in laboratorio un formicaio a cui fu posto sopra un vetro per le riprese.
Le formiche non si prestano volentieri ad essere impresse nella pellicola
poiché esse vivono e operano al buio e la luce le paralizza, vivono
in un mondo di odori, riconoscono l’ambiente con l’olfatto.
Per riprendere le formiche Alberto fu costretto ad utilizzare una pellicola
in bianco e nero, più sensibile alla luce.
La camera riprende dall’alto una battaglia fra le formiche rosse
e quelle nere, proprio grazie alla gru costruita da Alberto e collaboratori,
la camera potè avvicinarsi senza che si percepiscano i minimi movimenti.
È domenica nella foresta e la gente prende il taxi per andare allo
stadio: un rospo salta sulla tartaruga taxi che parte all’impazzata
con del fumo che esce da dietro.
Allo stadio della foresta ci aspetta un cronista d’eccezione, Nicolò
Carosio, famosissimo all’epoca che si prestò alla cronaca
di una partita tra scarabei.
Fu in Puglia che Alberto andò a recuperarli. Una volta portati
a Crocetta del Montello creò il terrario su di un tavolo dove potè
girare le scene di vita di questi scarabei e la partita fu poi montata
in un secondo tempo da Mario Serandrei, uno dei più grandi montatori
italiani.
Durante la partita c’è posto per tutto: i capitani che salutano
le squadre, il pubbico in delirio, i goal, il rigore, l’elicottero
pubblicitario (una libellula), le violenze negli spalti, le minaccie per
l’arbitro Grillo di Prato, che viene ad un certo punto mangiato
da un rospo.
Tra gli altri con Fernando girò "Le piante vivono" che
presentato alla Mostra d’arte cinematografica a Venezia, che organizzava
in collaborazione con l’università di Padova una rassegna
internazionale del film scientifico -didattico vinse e fu giudicato un
film di «eccellenti qualità didattiche e informative come
gli altri film presentati dallo stesso autore Gli Aracnidi, Gli Anfibi,
Gli insetti minori in cui si manifesta un elevato senso poetico della
natura. La realizzazione è molto curata, con un uso molto raffinato
del colore».
I ditteri (1959) Gli imenotteri,
I coleotteri vinsero il Bucranio di bronzo, Biologia del sesso
e I sauri furono premiati con il Bucranio d’argento.
Un altro documentario degno di nota è L’isola del
vetro (1961) girato con Fernando Armati, fu prodotto dal Corning
Glass Museum di New York, ricevette numerosi premi e riconoscimenti tra
cui il premio della Camera di Commercio di Monza e Milano, al festival
di Berlino e a Roma l’Osella d’oro. Il documentario riprende
la lavorazione del vetro da parte di maestri vetrai di Murano. Il commento
sonoro porta la firma di Mario Nascimbene.
Il silenzio della laguna è un documentario che
percorre le isole della laguna veneziana, firmato da Ancilotto e Armati
esso non ha alcun commento parlato, ad eccezione di un pezzo in cui la
camera riprende un famoso pescatore della laguna, chiamato deo de oro[2]
la cui specialità era raccogliere le cappe longhe con le dita dei
piedi. Nel documentario è ripreso mentre discute sulla vendita
di spigole. Un documentario originale e con una bellissima fotografia.
La BBC, utilizzò negli anni sessanta il materiale girato
da Alberto e Fernando per una serie scientifica dal titolo Look, presentata
da Peter Scott.
I punti di forza dei documentari di Alberto sono molti dal punto di vista
tecnico: la bellezza dell’immagine, l’armonia nel comporre
lìimmagine, la scelta e la capacità di riprendere soggetti
naturalistici con una forte componente estetica. Ma i documentari di Alberto
Ancilotto sono questo e molto di più. Sono documentari didattici
e scientifici, documentari che spiegano i fenomeni della scienza facendo
spettacolo, arrivando allo spettatore con nozioni, ma facendolo emozionare
e partecipare emotivamente. Durante tutto il corso della sua vita Alberto
Ancilotto dimostra un grande amore per gli animali, siano essi invertebrati
che vertebrati, dimostrandoci con un documentario, Caccia al camoscio,
la predilezione per un tipo di caccia ecologica.
I protagonisti dei suoi documentari non sono addestrati come animali da
circo, è Alberto e la sua troupe a seguire i tempi degli animali
e non viceversa.
A fine anni sessanta raggiunge il figlio Carletto in Kenya dove acquista
una farm.
Continua la collezione di farfalle
aggiungendo a quelle del trevigiano alcune specie africane, una delle
quali porta il suo nome perché non era ancora stata scoperta, poco
prima della morte con l’amica e collaboratrice Angelina Grollo,
pubblica per la Mondadori un libro fotografico sui bruchi, con la consulenza
dei prof f. Zangheri e Ruffo…370 foto a colori.
Nel 1971 muore a Treviso nella villa Felissent di proprietà della
moglie, dopo una malattia durata tre anni.
L’Associazione Italiana di Cinematografia scientifica di cui lui fu tra i fondatori gli dedicò la dicitura di poeta della natura perché riuscì ad essere scientifico senza dimenticare l’impatto con la natura, utilizzando tanta creatività studiando prima di tutto il comportamento degli animali proprio quando l’etologia era una scienza rimasta nei laboratori.
In un’epoca come la nostra, in cui fare spettacolo equivale a fare televisione, questo omaggio ad Alberto Ancilotto ci ricorda come si possa con la natura fare spettacolo, ci ricorda che la scienza non è un linguaggio a noi lontano, ma che molte cose che hanno l’aria di essere un prodigio esistono e ve le potete spiegare, dipende da quanta curiosità avete per ciò che vive intorno a voi.